Anche questo quadro è di autore ignoto e si ritiene, come le altre opere, della prima metà del XVIII sec., l'epoca della costruzione dell'Oratorio. Nell'Oratorio ha tutt'ora sede la Confraternita di Maria SS. della Mercede e di S. Carlo Borromeo fondata nel XVI secolo.  La Confraternita, una delle sei esistenti a Bronte, ebbe origine giuridica con rescritto regio del 10 settembre 1830, dato in Napoli dal Re borbonico Francesco I. La Confraternita, una delle sei esistenti a Bronte, ebbe origine giuridica con rescritto regio del 10 settembre 1830, dato in Napoli dal Re borbonico Francesco I.
Fu fondata da pii e devoti cittadini e da un considerevole numero di sacerdoti che si obbligarono di rimanere fedeli confratelli durante la loro vita.
Confermata dall'Autorità Ecclesiastica fu sempre una Confraternita di puro scopo religioso con obbligo di partecipare alle processioni e sopratutto di assistere ai funerali dei “fratelli” o dei loro familiari defunti e assicurare la loro sepoltura.
Possedeva un proprio oratorio per le funzioni e per le riunioni domenicali e un’altra Cappella al Cimitero, con annessa sepoltura pei Confratelli. Il 19 dicembre 1935-XIV, sempre con decreto reale, fu disposto il passaggio della Confraternita alla dipendenza dell'Autorità Ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione di essa, ai termini dell'art. 29, c) del Concordato con la Santa Sede. 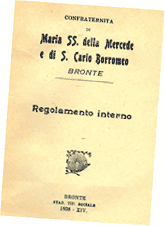 Da un nuovo Regolamento interno approvato nel 1936 (foto a destra) leggiamo che i fini della Confraternita di Maria SS. della Mercede e di S. Carlo Borromeo erano di «mantenere vivo tra i suoi iscritti lo spirito cristiano, facendo rifiorire il Culto al SS. Sacramento, la devozione alla Beata Vergine ed a S. Carlo Borromeo», «migliorare moralmente i suoi associati, ed aiutarli nei loro bisogni materiali» e «rendere degne esequie e assicurare onorata sepoltura ai defunti confratelli». Da un nuovo Regolamento interno approvato nel 1936 (foto a destra) leggiamo che i fini della Confraternita di Maria SS. della Mercede e di S. Carlo Borromeo erano di «mantenere vivo tra i suoi iscritti lo spirito cristiano, facendo rifiorire il Culto al SS. Sacramento, la devozione alla Beata Vergine ed a S. Carlo Borromeo», «migliorare moralmente i suoi associati, ed aiutarli nei loro bisogni materiali» e «rendere degne esequie e assicurare onorata sepoltura ai defunti confratelli».
Per quest’ultimo punto che, in definitiva era lo scopo principale della Confraternita e dell’adesione dei soci, all’art. 40 leggiamo ciò che dopo morte toccava di diritto ad ogni fratello, sorella od avventizio, le tre categorie di soci che componevano la Confraternita: «a) una messa bassa; b) sei candele da consumarsi in casa; c) accompagnamento a spalla dai confratelli dalla casa alla chiesa con l'intervento del clero e della confraternita e con torcette di gala spenti; d) coltre di gala sulla cassa ordinaria o sulla scalina; e) messa funebre cantata presente cadavere; f) suono a mortorio di sette campane oltre quella della nostra chiesa e della chiesa Madre nei due pedaggi; g) officiatura intera; h) catafalco e cassa ricoperta dalla coltre di gala quando il cadavere è chiuso in cassa ordinaria; i) numero cento candele e luce elettrica accese durante la funzione; h) accompagnamento dalla nostra chiesa allo Scialandro fino alla chiesa di Maria SS. delle Grazie da parte di tutti i confratelli e del R. P. Spirituale, con l'intervento del clero e della confraternita; m) cassa ordinaria in legno abete; n) carro funebre di III classe; o) inumazione; p) esumazione dopo 18 mesi, con nuova cassa; q) sarcofago cronologico nel vano della cappella a seconda la categoria cui apparteneva il confratello». Anche i soci delle altre confraternite brontesi (del SS. Sacramento, di Maria SS. della Misericordia, di Gesù e Maria, di S. Francesco e dell’Addolorata) avevano diritti consimili e bisogna dire che per i tempi antichi non era poco e che il contadino brontese viveva più tranquillo sapendo che alla sua morte c’erano i “fratelli” che pensavano a tutto.
|