Quasi alla fine, pi buffiniàri, prendere in giro e creare nei bambini l’attesa, faceva per loro a minnitta, piccola guastella simile ad una mammella; poi raccoglieva dal fondo della madia i ristatìgghi, i resti, ca rrascamaìlla, radimadia (foto 3), li mischiava alla crusca e faceva 'u pupillùni, pagnotta per il cirneco di casa, il cane Fido, dal nome classico e sempre presente in quasi tutte le famiglie per la guardia al cortile di galline e conigli ma anche per la caccia (foto 4). Ogni contadino amava la caccia, era il suo unico svago dal duro lavoro dei campi; possedeva a scupètta, fucile, chiamato anche frisciò (termine che potrebbe avere origini francesi, fichant, fuoco rientrante, oppure onomatopeico, fischio) che la domenica ripuliva dalla polvere da sparo e lubrificava; pesava e mischiava le polverine da sparo che pressava in ogni cartuccia, aggiungendovi alla fine i pallini di piombo, il cui effetto avrebbe assicurato alla famiglia il pasto proteico della domenica: u cunìgghiu savvàggiu cu sucu e i maccarrùni. Intanto la massaia su ogni pagnotta faceva col coltello un taglio a croce perché nel gonfiarsi non si sbuddissi, sformasse, copriva cu linzoru 'i lana, lenzuolo di lana grezza e coperte. La lievitazione del pane era lenta, circa due o tre ore, secondo della stagione e nei mesi invernali per accelerarla si poneva sotto il tavolo, a conca, il braciere, e per controllare a che punto fosse sollevava delicatamente le coperte, quasi a non disturbare, e quando il pane si presentava (foto 5) ca cammìsza strazzata, superficie appena fessurata, era il momento chi si llumàva u funnu, si accendeva il forno di pietra, costruito da esperti mastri, muratori, i quali conoscevano bene le tecniche di tiraggio e la tenuta del calore. La massaia metteva ad ardere i fraschi, fascine secche e spezzoni di tronchi che il capo famiglia aveva tagliato ca ccetta, con l’accetta. I legni li girava e rigirava cu spitu, lungo ferro appuntito per distribuirli in tutte le parti mentre i bambini, tenuti distanti dal forno, guardavano con occhi sbarrati e intimoriti lo scoppiettare della legna accesa. Il momento più importante era sapere quando il forno avrebbe raggiunto la giusta temperatura; entrava in scena l’esperienza che osservava la cupola interna del forno, i laterali e il pavimento finché non fossero diventati bianchi. La massaia raccoglieva la carbonella cu rrastrellu, rastrello, e u parittuni, paletta grande, e la chiudeva per spegnerla ndo stutafòcu, contenitore di ferro col coperchio (Foto 6). La carbonella in seguito veniva riutilizzava per scaldarsi, si riaccendeva nda conca, (foto 7) braciere, dopo avere eliminato i tizzuni, pezzi di legno non carbonizzati che emettevano fumo irrespirabile. Scopava dalla cenere il pavimento del forno con la scopa di stramma o ‘disa (foto 8) nome scientifico Ampelodesmos tenax (foto 9), pianta molto comune nell’area mediterranea e sub-montagna che cresce anche a Bronte ma non abbiamo notizie se qualcuno intrecciava le foglie dando la forma di scopa né chi le vendeva o se le ritirava da qualche paese. Per controllare la giusta temperatura spargeva un pugno di farina sul pavimento del forno e quando carbonizzava dimostrava che la temperatura era alta e ripassava la scopa bagnata per abbassarla. Era giunto il momento che la madre-maestra quasi intimava alla figlia-allieva di stare molto attenta: u funnu consza e sconsza, il forno combina e scombina e nelle sue mani era il destino della famiglia. Poi trasferiva le pagnotte una ad una sulla pala infarinata, le posizionava in forma circolare l’una distante dall’altra, chiudeva a bucca ro funnu, bocca del forno, ca ciappa, coperchio di ferro, sigillava con sacchi di lona, canapa, bagnati, perché il calore non fuoriuscisse. Iniziava la recita della preghiera propiziatoria tramandata da madre in figlia e ne proponiamo due: “Santa Rosa e Santa Margherita, russu ri crusta e riccu ri mullica (crosta croccante e morbida mollica)” “Trazsi pani ndo funnu (entra pane nel forno)
Gesù Bambinu veni o munnu (vieni al mondo)
Né liszu né passatu Gesù mio sacramentatu (che non sia poco lievitato né troppo)
San Braszùzzu criscìti u pani e laggàti u funnu (San Biagio allargate il forno se il pane non vi entra)
Santa Rosalia biancu e russu commu a ttia (sia colorito come il tuo viso)
Sant’Ághita s’è stortu vui u cunzati (San Agata se le forme non sono perfette aggiustatele voi)
San Giuseppi e San Giuvanni priàtici vui p’amuri divinu (intercedete per noi vi prego)
Cori 'i Gesù ammu fattu nui e ora faciti vui (Cuore di Gesù noi abbiamo fatto il possibile, ora pensateci voi)”. Per calcolare il tempo, se qualche massaia non possedeva l’orologio, seguiva i tocchi di quello della chiesa vicina o recitava il Rosario e, trascorsa la prima ora, controllava le pagnotte, le girava col rastrello per farle colorire da tutti i lati e quando era sicura che fossero cotte al punto giusto (foto 10), i sfunnava, le sfornava. Spolverava la base di ogni pagnotta da eventuale cenere, la poneva sul tavolo insieme alle altre e le copriva con coperte perché si raffreddassero lentamente prima di riporle nda càscia
(foto 5a), cassapanca, o ndo stipu, armadio dove si conservava anche u tumazzu cu i spezi, pecorino col pepe che le aspettava per invaderle ri ciàuru, del suo aroma. I bambini assistevano al “miracolo” che era avvenuto sotto i loro occhietti ansiosi e reclamavano i loro diritti: a minnita e u pani cunsatu, pane condito con olio, origano e ca saruti, augurio di buona salute e buon appetito! Il profumo del pane chiamava a raccolta il vicinato; c’era competizione fra chi lo faceva meglio e qualche massaia di fronte a pagnotte non perfette nella forma, poco o troppo cotte, esprimeva la sua disapprovazione, non verbale, ma smussiava, torceva il muso, affermando la sua superiorità. L’improvvisazione e la fantasia non trovavano spazio, nel rispetto delle diverse tradizioni di famiglia. È mia opinione che nel “fare” il pane le donne erano protagoniste assolute di gesti solidali e responsabili per una famiglia formatasi spesso con la rinuncia ad una storia d’amore per un matrimonio combinato.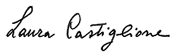 Marzo 2017 |