 In una antologia del ginnasio inferiore dei miei tempi c’era questa bella poesia di cui ricordo poco, sia del testo esatto e completo che dell’autore, ma ricordo bene sia il concetto della sacralità del pane, come cibo del corpo che dell’anima; infatti l’Eucaristia è simboleggiata proprio dal pane. In una antologia del ginnasio inferiore dei miei tempi c’era questa bella poesia di cui ricordo poco, sia del testo esatto e completo che dell’autore, ma ricordo bene sia il concetto della sacralità del pane, come cibo del corpo che dell’anima; infatti l’Eucaristia è simboleggiata proprio dal pane.
Sulla sacralità del pane come cibo diremo man mano che parleremo di esso e della sua confezione. Credo che molti ragazzi di oggi sappiano poco o nulla del pane, anche perché esso è poco consumato in quanto è stato in parte sostituito da tante “merendine” ed altri surrogati, come patatine “et similia”. Una volta in quasi tutte le famiglie, specialmente nei paesi ad economia agricola, all’epoca della mietitura e della trebbiatura[1], si comprava il grano sufficiente per un anno; esso poi, un poco alla volta, si mandava al molino (ce n’era uno ad acqua sul Simeto vicino a Maniace e al Castello Nelson) meccanico, dove veniva macinato e diventava farina. Questa, allo stato naturale era chiamata integrale e veniva usata dalla gente più povera che non voleva perdere nulla; setacciata con diversi tipi di crivelli, invece, dava o la farina 0, o quella 00, oppure la semola; da queste operazioni si ottenevano degli scarti che erano la crusca[2] e il cruschello, che servivano per alimentare gli animali, galline e maiali, mentre oggi sono usati anche per curare certi disturbi causati dalla vita sedentaria o dallo stress, e sono venduti a caro prezzo in farmacia o in erboristeria.
 La farina così ottenuta e setacciata veniva usata in casa o per il pane, o per la pasta o per i dolci. La farina così ottenuta e setacciata veniva usata in casa o per il pane, o per la pasta o per i dolci. Il pane veniva fatto in casa, e andare a comprare il pane al panificio era considerato una anomalia che deponeva male nella considerazione della famiglia. In casa si faceva il pane ogni settimana e gli arnesi per la sua confezione erano, oltre “u crivu”, già nominato come crivello, “a mailla”, la madia, dove la farina veniva impastata con acqua tiepida, sale e lievito naturale[3]. Lavorato bene questo impasto con le mani e con i pugni per circa mezz’ora, si passava a fare le forme di circa un chilo ciascuna e si mettevano su un tavolo di legno coperto da una tovaglia bianca; quando si era esaurita questa operazione, con i rimasugli di pasta che si ottenevano raschiando bene “‘a mailla“, si faceva “‘a minnitta”, un panino che, dal modo di rigirarlo con la mano, assumeva la forma di un piccolo seno, donde il nome in dialetto.
 Finita quest’ultima operazione con una certa sveltezza, per non fare raffreddare i pani, si coprivano prima con un’altra tovaglia bianca e poi con una “butana “, una di quelle coperte di lana, tessute in casa con i cascami di vecchie lane di diversi colori. Finita quest’ultima operazione con una certa sveltezza, per non fare raffreddare i pani, si coprivano prima con un’altra tovaglia bianca e poi con una “butana “, una di quelle coperte di lana, tessute in casa con i cascami di vecchie lane di diversi colori. Il calore, in circa un’ora, a seconda della temperatura esterna dovuta alle stagioni, faceva lievitare il pane. Nel frattempo la massaia aveva acceso il forno di casa che generalmente si trovava in un angolo della grande cucina, bruciando legna o gusci di mandorle o anche sansa. Quando il forno era caldo al punto giusto, allora non c’erano i termometri per misurare quelle temperature, e si regolava in base al colore che avevano assunto i mattoni che costituivano la bocca del forno, e il pane era lievitato al punto giusto, e ciò si vedeva dal modo e da quanto esso era cresciuto, la massaia tirava fuori, con un rastrello (rrastrilluzzu) ed una paletta di ferro (parittuni), tutto il fuoco che, messo in un grande recipiente di ferro con relativo coperchio “u stutafocu”, diventava carbonella che poi si metteva nella “conca“, cioè il braciere che serviva per riscaldarci mettendoci intorno al “cunchèri”[4]. Pulito, sempre con grande sveltezza, con uno straccio inzuppato di acqua, il piano di cottura, in modo che il pane non potesse avere pezzetti di carbone, con una lunga pala di legno infornava ad uno ad uno i pani e poi, benedicendo con un segno di croce e recitando la preghiera di rito: “Santa Rosa e Santa Maggarita, russu ri crusta e chinu ri mullica!”, chiudeva, con una lamiera a misura, la bocca del forno in modo che il calore non si disperdesse. La lunga e faticosa operazione era finita e a questo punto la massaia, asciugandosi il sudore causato dalla fatica e dal calore, si sedeva, (finalmente!), attendendo la cottura del pane.  Anche il tempo della cottura era misurato dall’esperienza e guardando di tanto in tanto, con una rapida apertura dello sportello, perché con esistevano le “istruzioni per l’uso”, e quando il lavoro era riuscito e il profumo del pane si spandeva per la casa e si sentiva anche fuori, la massaia era felice e innalzava una muta preghiera a Dio o alla Sua dolce Madre. Anche il tempo della cottura era misurato dall’esperienza e guardando di tanto in tanto, con una rapida apertura dello sportello, perché con esistevano le “istruzioni per l’uso”, e quando il lavoro era riuscito e il profumo del pane si spandeva per la casa e si sentiva anche fuori, la massaia era felice e innalzava una muta preghiera a Dio o alla Sua dolce Madre.
Se in casa in quel momento c’erano ragazzi o bambini, essi accorrevano, attratti da quel profumo di cui abbiamo perduto il ricordo, chiedendo a gran voce: “‘a minnitta, ‘a minnitta“; e la mamma, amorevolmente, tagliava orizzontalmente a metà quel dolce e profumato panino, che ricordava il seno materno, e, conditolo con olio e sale, lo divideva ai suoi bambini che ne erano ghiotti e felici. Ancora a proposito della sacralità del pane, ricordata, del resto, nel Padre Nostro, esso veniva utilizzato fino all’ultimo “tozzo”, o per i poveri o per gli animali. Durava in genere anche otto giorni, proprio perché era a lievitazione naturale; mentre oggi che si usa, anche per i tipi di pane più raffinati e sofisticati, il lievito di birra, il pane della mattina può risultare immangiabile la sera stessa, immaginiamo il giorno dopo. Ora si usa metterlo nel freezer ed è mangiabile appena scongelato e riscaldato, ma subito dopo si sfalda e si pietrifica di nuovo. Siccome spesso era scarso o mancava del tutto il companatico[5], ai bambini, per consolarli, si diceva “mangia il pane asciutto (appunto, senza null’altro), che ti vengono gli occhi più belli!”; e i contadini o anche qualche operaio, quando venivano richiesti cosa avevano mangiato, spesso, rispondevano: “pani e cutellu”, per significare col termine coltello, che serviva per tagliare il pane, la mancanza di companatico.  La colazione di mio nonno, e credo di molti artigiani, consumata in bottega verso le 10, consisteva in pane, formaggio e qualche ortaggio di stagione (acci, rapanelli, lattuchi) o altro, seguiti da un quartino di vino. La colazione di mio nonno, e credo di molti artigiani, consumata in bottega verso le 10, consisteva in pane, formaggio e qualche ortaggio di stagione (acci, rapanelli, lattuchi) o altro, seguiti da un quartino di vino.
Invece l’aperitivo (ma allora non si usava questo termine, ma “u biccheri”), della sera, dopo il lavoro e prima di rincasare, definitivamente, per la cena, consisteva nell’andare a bere un bicchiere di vino, accompagnato dai “luppini“ o dai “cacucciuricchi”, in una delle cantine delle migliori famiglie, con gli amici, generalmente dello stesso mestiere o parenti, con i quali si discorreva dei fatti del giorno e della politica, che il più delle volte riguardava l’amministrazione comunale o il lavoro. La cena serale era dedicata a raccogliere tutta la famiglia attorno alla “conca” prima, se era inverno, e attorno alla grande tavola rotonda dove si sostava anche dopo aver finito; la tavola veniva sparecchiata, ma non si toglievano né il pane né il vino, forse per un inconsapevole ricordo dell’Ultima Cena, in cui fu istituita l’ Eucaristia, rappresentata, appunto, dal pane e dal vino[6]. Quando, poi, si mettevano via questi due alimenti, chi eseguiva l’operazione baciava il pane toccandolo con le dita che poi portava alle labbra. Infine ci si fermava ancora un poco per ascoltare la lettura di qualche libro da parte di mia zia Ciccia, la quale amava i classici dell’ ‘800, anche stranieri, che poi provocavano accesi commenti fra i familiari. Bari, 21 gennaio 2005
Nicola Lupo |
NOTE
[1] Mietitura e trebbiatura sono due fasi della raccolta del grano: la prima consiste nella falciatura, cioè tagliare con la falce la pianta del grano o di altri cereali, e la seconda consiste nel separare i chicchi del grano o di altri cereali dal resto della pianta tagliata.
Queste operazioni una volta si facevano a mano, mentre oggi ci sono macchine che falciano, trebbiano e imballano la paglia da un lato, mentre insaccano il grano dall’altra. Vedi Lupo Nicola, Fantasmi, Bolo, pag. 35 e segg. [2] Questo nome, crusca, è stato scelto nel 1583 per una Accademia, detta appunto della Crusca, che aveva il compito di salvaguardare la purezza della lingua italiana; e pertanto ha compilato a tale scopo un Vocabolario dello stesso nome. [3] A proposito del lievito naturale devo raccontare come si faceva per trovarlo: era semplice e tradizionale e rappresentava uno dei segni della solidarietà che legava le famiglie del vicinato: chi doveva fare il pane dava voce alle vicine in cerca del lievito, chi lo aveva lo dava senz’altro; esso era costituito da un certo quantitativo di impasto messo da parte in un pentolino di coccio, a disposizione di chi ne avesse bisogno e lo chiedesse.
Colei che aveva avuto il lievito a sua volta metteva da parte, nello stesso pentolino che aveva ricevuto, un po’ del suo impasto e lo restituiva alla vicina o lo dava ad altra vicina che ne aveva bisogno: era una specie di catena di S. Antonio, di solidarietà. [4] La “conca” era un recipiente di lamiera di ferro o di rame con manici di ottone in cui si metteva il fuoco per riscaldare gli ambienti, messo sul “trispitu”, o le persone che, in quel caso, si mettevano intorno al “cuncheri”, che, come dice la parola, era una pedana di legno circolare a forma di ciambella, che nel buco centrale ospitava “‘a conca” e, sollevata da terra da piccoli sostegni, serviva per poggiarvi i piedi in modo da riscaldarli. Le donne, se stavano troppo vicino alla “conca”, si procuravano i “ròrruri” che erano delle piccole scottature a forma circolare, dolorose ed antiestetiche, alle gambe o anche più su.
Per evitare i dannosi effetti dell’ anidride carbonica, che si sviluppava con la combustione del carbone o della carbonella, si doveva fare accendere bene il carbone fuori all’aria, e per profumare l’ambiente si faceva bruciare sul braciere qualche buccia di arancia. [5] Companatico, tutto ciò che si mangia assieme al pane, secondo la definizione, è, forse, un termine poco conosciuto e poco usato, perché esso è diventato o il secondo o addirittura il primo, mentre il pane qualche volta, ne assume la funzione. [6] A proposito del pane e del vino e del loro significato religioso, ancorché inconscio, ricordo il seguente detto brontese che dice: “Pane e vinu s’ invita u parrinu“.
Esso, oltre alla essenzialità dei due alimenti, che sono sufficienti per invitare il prete, uno dei massimi esponenti dell’autorità locale, oltre al sindaco o podestà, a seconda dei periodi politici, e al maresciallo dei Carabinieri, rappresenta proprio i componenti del sacrificio dell’ Eucaristia, e quindi, unifica nell’ immaginario collettivo del popolo ignorante, ma devoto, il cibo del corpo con quello dell’ anima, che danno la serenità fisica unitamente a quella spirituale.
Ma penso anche che la “religiosità”, al di là di qualunque sovrastruttura chiesastica, che legava la gente a Dio attraverso la richiesta del “pane quotidiano“ , contenuta nel Padre Nostro, sia diminuita o quasi scomparsa, a causa del benessere, raggiunto o agognato, che ci sommerge di beni vari e spesso superflui, ma chiamati “esigenze”, e ci fa dimenticare l’ essenziale sia sul piano fisico che spirituale. |
 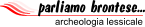
Ti potrebbe piacere anche: Pane e... altro nella tradizione, di Laura Castiglione |