L’origine e il significato dei cognomi brontesi di Pietro Spitaleri Perdicaro Quando nascono i primi cognomi?, I 119 cognomi analizzati, Classi cognominali, L'origine dei toponimi, L'origine linguistica
Forse pochi sanno che l’Italia detiene nel mondo il primato per il numero dei cognomi: ben 350.000 forme cognominali, in media un cognome ogni 8600 italiani! Tantissimi, se si pensa che in Cina, a fronte di una popolazione che ha superato ampiamente il miliardo di abitanti, si riscontrano appena un migliaio di cognomi.
Quando nascono i primi cognomi?
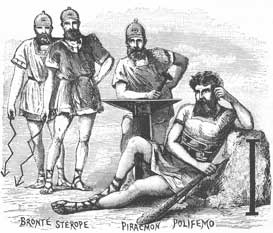 I Romani per riconoscersi usavano il praenomen (corrispondente al nostro nome di battesimo) e il nomen (il nostro cognome), che indicava la gens (la famiglia) di appartenenza dell’individuo. Solamente in epoca tarda, a partire dall’età di Silla, al praenomen e al nomen poteva aggiungersi il cognomen: una sorta di soprannome, nel caso in cui bisognasse distinguere individui aventi identici praenomen e nomen. I Romani per riconoscersi usavano il praenomen (corrispondente al nostro nome di battesimo) e il nomen (il nostro cognome), che indicava la gens (la famiglia) di appartenenza dell’individuo. Solamente in epoca tarda, a partire dall’età di Silla, al praenomen e al nomen poteva aggiungersi il cognomen: una sorta di soprannome, nel caso in cui bisognasse distinguere individui aventi identici praenomen e nomen.
È a partire dalla fine del Medioevo che inizia il processo di formazione dei moderni cognomi italiani, coprendo un arco temporale che si concluderà tra il Settecento e l’Ottocento. Dalla fine della potenza romana e fin verso l’Ottavo secolo, il riconoscimento di una persona poggiava ancora sull’adozione del semplice nome di battesimo (l’antico praenomen latino). Tre erano i sostrati linguistici su cui poggiava il repertorio onomastico alto-medievale: al più antico, quello latino, si era sovrapposta l’onomastica cristiana, che aveva mantenuto molti nomi pagani, integrandoli con l’apporto di nomi biblici. Infine, il sostrato più recente, l’onomastica dei popoli germanici (goti, longobardi, franchi), che si erano avvicendati nel dominio della penisola italiana. Inizialmente, l’uso dei nomi germanici rimase confinato al loro specifico ambito etnico e ciò permise ancora la sopravvivenza dei sostrati più antichi (latino e cristiano). Fino all’Ottavo secolo, l’esistenza di tre distinte tradizioni linguistiche offriva dunque un ben differenziato e articolato patrimonio onomastico, rendendo ancora possibile, senza incorrere in frequenti omonimie, l’uso di un solo nome personale. Tale sistema era sufficiente in una realtà chiusa e statica quale quella feudale, caratterizzata da uno scarso dinamismo demografico. Ma, alla fine del primo millennio, la rinascita demografica della popolazione europea, il rifiorire dei traffici e dei commerci, la ripresa dell’inurbamento, imporranno un diverso sistema di identificazione delle persone, che evitasse i sempre più frequenti fenomeni di omonimia. Anche il progressivo prevalere dei nomi germanici, e la conseguente decadenza dell’onomastica latina e cristiana, determinarono una semplificazione nella scelta dei nomi personali, che contribuì ad alimentare i casi di confusione nella identificazione delle persone. 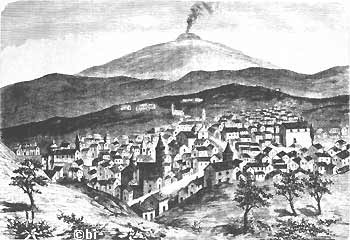 L’uso del solo nome di battesimo si rivelò insufficiente. Si impose dunque la necessità di coniare nuovi epiteti da aggiungere al nome individuale. I cognomi nacquero come veri e propri soprannomi personali. Come tali, essi condensavano, nel loro “significato”, un qualche aspetto della condizione personale degli individui a cui facevano riferimento. L’uso del solo nome di battesimo si rivelò insufficiente. Si impose dunque la necessità di coniare nuovi epiteti da aggiungere al nome individuale. I cognomi nacquero come veri e propri soprannomi personali. Come tali, essi condensavano, nel loro “significato”, un qualche aspetto della condizione personale degli individui a cui facevano riferimento.
Un individuo che, per esempio, si chiamasse di nome Giorgio ed esercitasse il mestiere di fabbro, poteva essere soprannominato “Giorgio Ferraro”.
I suoi figli, a loro volta, avrebbero ereditato il soprannome del padre e costoro lo avrebbero trasmesso ai propri discendenti: nasce la famiglia dei “Ferrari”. Nell’arco di non molte generazioni dunque, un soprannome, divenuto ereditario, si trasformava in cognome. Esso smarriva la sua originaria valenza di “soprannome personale”. Essendo riferibile a più membri di una medesima famiglia, la sua funzione era di distinguere, all’interno di comunità cittadine ormai numerose, non più e non solo le singole persone, quanto piuttosto un gruppo famigliare. Sarà il Concilio di Trento, a metà del Cinquecento, che imporrà l’istituzione dei primi registri battesimali, dove, accanto al nome proprio, veniva fatto obbligo al sacerdote di annotare anche il casato del neonato. Successivamente, quando con il sorgere dell’anagrafe, tra Settecento e Ottocento, inizierà la registrazione civile dei cognomi, il sistema cognominale europeo sarà quasi del tutto strutturato e stabilizzato.
I 119 cognomi analizzati
I cognomi da me analizzati ascendono a 119. Basandomi sul criterio della frequenza, sono stati rilevati dall’elenco telefonico del 2007/2008, dunque essi non esauriscono la totalità dei cognomi presenti a Bronte (sulle forme omesse, mi riprometto di tornare successivamente, scusandomi anticipatamente con quei lettori che non troveranno il loro cognome). Di ogni forma, ho tentato di suggerire una esplicazione etimologica, ovvero il significato originario, nonché la probabile origine linguistica. Per alcuni si forniscono più spiegazioni, disposte in ordine di decrescente plausibilità esplicativa (dalla più probabile alle meno convincente). Pochi sono invece accompagnati da un punto di domanda (?), a voler significare che l’indicazione esplicativa del significato rimane dubbiosa.
Mi preme di ricordare che, non essendo l’onomastica una scienza esatta, i dati riportati possono essere suscettibili, sulla scorta di indagini e ricerche nuove e più approfondite, di correzioni e revisioni. Ecco l’elenco dei cognomi con la relativa esplicazione del significato: AMATO: (dal latino Amatus), “amato da Dio”. Cognome diffuso tra gli ebrei (in ebraico Chabib, da cui la forma cognominale “Cabibbo”, diffusa in Sicilia nelle provincie di SR e RG). È anche nome di un fiume e di una località in provincia di Catanzaro. ANASTASI: (dal greco tardo), “risorto”. ATTINA’: (dal greco tardo), “colui che pettina”. In Grecia esiste il cognome Ktenàs. AVELLINA: dal nome della città Avellino. AZZARA: (dall’arabo), “fiore”. Cognome presente anche tra gli ebrei.BARBAGIOVANNI: nome composto da “barba” (dal latino, “uomo barbuto, autorevole”) e “Giovanni”; dunque, “saggio Giovanni”. BASILE: (dal greco medievale), “regale”. BATTICANI: nome composto di origine araba : wadi (“vallone”) e ayn (“sorgente”); dunque, “sorgente nel vallone”. In Sicilia esiste un torrente Batticani, affluente del Belice. BERTOLONE: accrescitivo del sic. bertula (“bisaccia”), dunque “grossa bisaccia”. In senso figurato, “uomo grasso”.  BIUSO: nome proprio (dal lat. medievale), Abiosus. BIUSO: nome proprio (dal lat. medievale), Abiosus.
BONACCORSO: nome augurale di origine medievale, “Buon aiuto” oppure “bene accolto”. BONINA: diminutivo del nome proprio medievale Bona. BONSIGNORE: dal latino medievale “Buon signore”. BURRELLO: in siciliano bureddu, “intestino”. Oppure dal francese borrel: “carnefice”. CALA’: (dal greco), “Bello”. CALANNA: (dal greco), “buona Anna” (nome augurale). CALI’: (dal greco medievale), “Buona” (nome augurale). CAMUTO: (dall’arabo), “grazie a dio”. CANNATA: “vaso di creta per acqua” (dal siciliano, derivato però dal greco medievale). CAPACE: “abile” (dal latino). È il nome di una località del Palermitano nella forma “Capaci”. CAPIZZI: dal nome (di origine tardo greca) del centro montano del Messinese. CARACI: (dal greco) “Grazia di Dio” (nome augurale). CARTILLONE: accrescitivo di “Cartello” (nome proprio di origine tardo greca). CARUSO: (dal siciliano carusu, derivato dal verbo accarusare, “capitozzare”, ovvero “potare gli alberi al tronco”): “garzone”, “ragazzo inesperto”. CASERTA: dal nome della città campana (dal latino medievale “casa irta”: “borgo situato in un sito impervio”). CASSARA’: (dall’arabo), venditore di stuoie”. CASTIGLIONE: (dal latino medievale) “piccolo castello”. Esistono diverse località italiane con questo nome; la più vicina a Bronte è Castiglione di Sicilia. CATANIA: dal nome (di origine greca) della città etnea; oppure, dall’arabo, “granone”. È il quarto cognome per diffusione a Bronte. CIMBALI: dal siciliano (cìmbalu), “cembalo”. CIPOLLA: (dal latino) “cipolla”. CIRALDO: variante del termine siciliano ceraulo (in calabrese ceravularu, ciaraulu). Esso deriva dal greco e significa “suonatore di corno”, strumento con il quale tale misterioso personaggio attirava su di sé l’attenzione della gente. Sorta di stregone-guaritore, figura erratica, il ceraulo andava girando di paese in paese (è attestata la sua presenza in tutta l’Italia meridionale), recando con sé dei serpenti che adoperava a scopo terapeutico. In particolare, nell’ambito delle credenze popolari legate alla civiltà agricola, si riteneva che i cerauli possedessero poteri soprannaturali tali da poter guarire gli uomini dai morsi degli animali velenosi. Ad accrescere l’aura mitica che circondava la figura dei cerauli concorreva anche la credenza che essi fossero diretti discendenti di S. Paolo, colui che per primo aveva domato il serpente (per antonomasia, simbolo del male nella mentalità popolare). Il prestigio del ceraulo decadde con il tramonto delle credenze dell’arcaico mondo contadino e con la scomparsa delle pratiche magiche. Il termine andò acquisendo, nel suo nuovo significato figurato, la valenza negativa di “imbroglione”, “ciarlatano”. CIRAMI: nome siciliano di Cerami, località dell’Ennese (dal greco, “vaso di terracotta”). CONTI: (dal latino), “compagno”. Il cognome è di origine tortoriciana. CORDARO: (dal latino medievale), “fabbricante di corde”. COSTANZO: nome proprio derivante dal latino “Costantino”: “che è dotato di forza, di tenacia” (cognome di origine tortoriciana). CURRENTI: “colui che corre” (dal verbo latino currere). D’AQUINO: “proveniente da Aquino”, centro della provincia di Frosinone. DE LUCA: “di Luca”; in origine “figlio di Luca”, poi “appartenente alla famiglia dei Luca” (nome di origine latina). DESTRO: “abile” (dal latino). DI MARCO: (nome di origine latina) “di Marco”; in origine “figlio di Marco”, poi “colui che appartiene alla famiglia dei Marco”.  DI SANO: (nome di origine latina) “che è figlio di genitori integri fisicamente e moralmente”. DI SANO: (nome di origine latina) “che è figlio di genitori integri fisicamente e moralmente”.
DI VINCENZO: “figlio di Vincenzo”; in seguito “membro della famiglia dei Vincenzo” (dal latino: “colui che risulta vincitore”). FALLICO: (dal greco), “ciottolo”. FARANDA: nome proprio greco, Farandas. FAVAZZA: dispregiativo di “fava”. FAZIO: nome proprio derivante dall’abbreviazione di “Bonifazio” (dal latino: “colui che fa del bene”). FOTI: (dal greco), “luce”. Il cognome potrebbe derivare da mestieri che hanno attinenza con la “luce” e col “fuoco”. FRANCO: (dal germanico), “libero”; oppure dal nome di una località navarrina. È cognome ricorrente anche presso gli ebrei (un esempio famoso è quello di Anna Frank, autrice del famoso “Diario”). GALATI: dall’omonimo comune messinese (dal greco medievale, “latte”). Il cognome è originario di Tortorici. GALVAGNO: nel Messinese esiste una località con questo nome, che deriva dal nome proprio “Galvano”. GANGI: dall’omonimo comune palermitano (parola di probabile origine tardo greca). GATTO: (dal latino tardo), “gatto”. GERMANA’: (dal greco) “campo di segale”. GORGONE: dal greco, “mostro” ; oppure dal francese, “baratro” (?). GRASSIA: (dal greco), “obliquo”, “trasversale”(?). GRECO: (dal latino), “greco”. In epoca medievale, gricu, nel dialetto siculo, era sinonimo di “albanese”. Nel significato figurato vuoi dire “uomo astuto, furbo”. GRIGOLI: nome proprio,”Gregorio” (dal greco medievale). GULINO: nome proprio derivante dall’abbreviazione di “Ugolino”. GULLOTTO/I: in greco: “mutilo”, “storto”. In calabrese gullu significa “senza corna”. IMBROSCIANO: variante di “Ambrosiano” (dal nome proprio, di origine greca, “Ambrogio”: “Immortale”). INCOGNITO: “non conosciuto”. Ha il medesimo significato di cognomi quali: Diolosà, Esposito, Degli Esposti, Trovato, Innocenti, Diotallevi.
 ISOLA: nome proprio femminile, “Isola”. ISOLA: nome proprio femminile, “Isola”. LAGANA’: (tardo greco), “ortolano”, “erbivendolo”. LAZZARO: nome personale di origine ebraica: “Eleazaro”, “colui che è assistito da Dio”.. LEANZA: “da lianza” (siciliano), “dall’alleanza” , ovvero “colui che proviene dalla (o che appartiene alla) “Alleanza” tra Dio e il popolo ebraico”. Oppure, dall’italiano antico leanza: “lealtà”. LEMBO: “catino di terracotta” (termine siciliano). LIUZZO: vezzeggiativo dei nomi propri “Leo”o “Elia”. A Messina esiste un rione con questo nome. Cognome diffuso anche a Tortorici. LOMBARDO: in età normanna, i “lombardi” erano indistintamente tutti gli immigrati in Sicilia provenienti dall’Italia nord-occidentale. Ma nel siciliano antico lummardu era sinonimo di “droghiere”, “venditore di alimenti”, poiché molti erano i lombardi che venivano in Sicilia ad esercitare tale mestiere. LONGHITANO: “che proviene da Longi”, comune del messinese. È il cognome più frequente a Bronte. LUCA: nome proprio (di origine latina) derivato da “Lucio” (“luminoso”) o da “Lucano” (“abitante della Lucania”). LUPICA: forse dal napoletano luppeca, “upupa”. LUPO: (dal tardo latino), “lupo”. Centrale era, nella mitologia fondativa romana, la Lupa, nutrice di Romolo e Remo. Durante il Medioevo, è assai diffuso anche nell’onomastica germanica, il nome wulf, simbolo di valore e di forza; senza dimenticare, infine, il nome proprio longobardo “Lupo”, dal verbo luba: “amore”. MANCANI: “addetto al mangano”, “operaio tessile”. Il mangano era una macchina a cilindri per lisciare e rendere più morbidi i tessuti. |
RUBINO: “rosso” (dal latino rubeus). In senso figurato “bello come un rubino”. Ma potrebbe anche derivare dall’ebraico ruben, “figlio della Provvidenza” (cfr. il cognome ebraico Rubinstein: “pietra rossa” “rubino”). RUSSO: dal siciliano russu, “rosso (di carnagione, di capelli). SACCULLO: “piccolo sacco” (dal siciliano). SAITTA (dal siciliano): “fulmine”, ma anche “trottola”; oppure (dall’arabo sayyd), “signore”. È il terzo cognome per frequenza a Bronte. SANFILIPPO: dal nome del comune dell’ennese S. Filippo d’Agira. SCALISI: “proveniente da Scalea” (località calabrese). SCHILIRO’: cognome di origine albanese, “duro, forte” (dal greco). È il quinto cognome per frequenza a Bronte. SCIACCA: dal nome della cittadina agrigentina. Ma anche, “fenditura” (dal siciliano sciaccare: “spaccare”, “fendere”, verbo di origine araba, shaqqah). SPITALERI: (parola siciliana) dal latino medievale hospitalarius, derivato da hospitium, termine con cui si designavano le strutture di ospitalità per i viandanti e i forestieri, ma anche gli asili per gli orfani. L’hospitalarius era dunque l’addetto a tali ricoveri. Posteriore ad hospitium è invece il termine hospitalis, che indicava il luogo di cura per i malati. Di conseguenza, il termine “spitaleri” assumerà il significato più moderno di “servente di un ospedale”. In epoca medievale l’ospitalità e l’assistenza agli infermi, agli orfani e ai trovatelli, era prerogativa degli ordini monastici e delle chiese principali.
Nei registri parrocchiali più antichi della Chiesa Matrice di Bronte, il cognome Spitaleri è diffusissimo ed ho motivo di supporre, sulla scorta delle mie ricerche d’archivio, che Bronte abbia costituito l’“epicentro”, il fulcro dell’irraggiamento di tale forma cognominale negli altri paesi etnei. Proprio per l’alta diffusività del cognome, il filosofo brontese Nicola Spitaleri e i suoi familiari, per esigenze di distinzione di ceto, adottarono la forma “Spedalieri”, che è la versione toscanizzata della primitiva versione “Spitaleri”, dando così origine ad una nuova casata. TIRENDI: nome proprio (dal greco), “Terenzio”. UCCELLATORE: (dall’italiano), “chi pratica l’uccellagione” VITANZA: nome astratto derivato da “vita”(?). ZERBO: (dal greco medievale), “mancino”. ZINGALE: (dal greco medievale), “calzolaio”.
Classi cognominali
Sulle base del loro significato originario, le 119 forme cognominali brontesi esaminate sono state ripartite in “classi” (per i cognomi di cui sono stati indicati più possibili significati, questi sono stati considerati integralmente e come tali classificati, per cui capiterà di vedere alcune forme cognominali inserite in più gruppi):
 - Cognomi derivanti da nomi personali: - Cognomi derivanti da nomi personali:
Amato, Anastasi, Barbagiovanni, Basile, Biuso, Bonaccorso, Bonina, Calanna, Camuto, Caraci, Costanzo, Faranda, Fazio, Grìgoli, Gulino, Imbrosciano, Isola, Lazzaro, Liuzzo, Luca, Marcantonio, Marino, Martelli, Meli, Pace, Pafumi, Politi, Ponzo, Prestianni, Rubino, Tirendi (totale n. 31). - Cognomi derivanti da soprannomi scherzosi, spregiativi, ironici, centrati su caratteristiche fisiche o caratteriali o comportamentali riferibili al singolo:
Bertolone, Bonsignore, Calà, Calì, Capace, Cartillone, Caruso, Conti, Currenti, Destro, Di Sano, Foti, Franco, Gorgone, Grassia, Gullotto, Incognito, Meli, Musarra, Mirenda, Papotto, Pappalardo, Petronaci, Politi, Reale, Rubino, Russo, Saitta, Schilirò, Zerbo (totale nn. 30). - Cognomi toponimi ed etnici. I toponimi indicano la località di provenienza, gli etnici l’appartenenza a etnìa:
Toponimi brontesi sono: Avellina, Batticani, Capizzi, Caserta, Castiglione, Catania, Cirami, D’Aquino, Franco, Galati, Galvagno, Messina, Minio, Pace, Palermo, Piazza, Sanfilippo, Sciacca. Etnici sono invece: Greco, Lombardo, Longhitano, Messineo, Romano, Scalisi (totale nn. 24). - Cognomi tratti dal mondo della natura:
Azzara, Catania, Cipolla, Favazza, Gatto, Germanà, Lùpica, Lupo, Marullo, Meli, Montagno, Pàparo, Pecorino, Pinzone, Rappazzo, Rizzo, Saitta (totale nn. 17). - Cognomi indicanti un mestiere, una professione, una carica:
Attinà, Burrello, Cassarà, Ciraldo, Cordaro, Laganà, Lombardo, Màncani, Minissale, Orèfice, Portaro, Spitaleri, Uccellatore, Zingale, (totale nn. 14). - Cognomi tratti da oggetti del mondo del lavoro e della casa:
Bertolone, Cannata, Cìmbali, Fàllico, Lembo, Pruiti, Romano, Saccullo, Saitta (totale nn.9). - Cognomi patronimici o matronimici (derivano dal nome del padre o della madre):
De Luca, Di Marco, Di Vincenzo (totale nn.3). - Cognomi indicanti parte del corpo umano:
Burrello, Marullo (totale nn. 2). - Cognomi derivanti da nomi astratti:
Lenza, Vitanza (totale nn. 2). Come si può facilmente osservare, più del cinquanta per cento dei cognomi brontesi analizzati deriva da nomi personali, soprannomi e patronimici. All’origine della nascita dei cognomi spesso concorreva la “cristallizzazione” di un nome proprio o di un soprannome personale, che da un individuo si trasmetteva ai suoi discendenti, dando origine ad una famiglia ben distinta (in parte, qualcosa di simile accade ancora oggi, nei nostri paesi, con i soprannomi - ’ngiùrii o pecchi - mediante i quali, soprattutto gli anziani, identificano persone e famiglie, senza far ricorso in alcun modo ai “cognomi ufficiali” dell’anagrafe). Variegato è l’universo dei cognomi brontesi derivati da nomi propri.
Degni di nota, in particolare, gli “augurali” e i “granulatori” (nomi indicanti buoni auspici per il nascituro o l’infante) - tra cui, l’“amato da Dio” (“Amato”), il “risorto” (“Anastasi”), il “ben accolto” (“Bonaccorso”), l’ “assistito da Dio” (“Làzzaro”), il “figlio della Provvidenza” (“Rubino”), (il bimbo) “dolce come il miele” (“Meli”), che è, per i genitori, “felicità” (“Musarra”).  Tra i soprannomi personali, ritroviamo: un grassone (“Bertolone”), un mangione (“Pappalardo”), un “mostro” di bruttezza (“Gorgone”), uno storpio (“Gullotto”), un mancino (“Zerbo”), un “dritto” (“Schilirò”), un “poco di buono” (“Grassia”), un ragazzo imberbe (“Caruso”), un “signore benevolente (“Bonsignore”), oppure, semplicemente, un “signore” (“Saitta”), un tipo con l’aspetto da “pretino” (“Papotto”), un “compagnone” (“Conti”), uno “bello come un rubino” (“Rubino”), etc. Tra i soprannomi personali, ritroviamo: un grassone (“Bertolone”), un mangione (“Pappalardo”), un “mostro” di bruttezza (“Gorgone”), uno storpio (“Gullotto”), un mancino (“Zerbo”), un “dritto” (“Schilirò”), un “poco di buono” (“Grassia”), un ragazzo imberbe (“Caruso”), un “signore benevolente (“Bonsignore”), oppure, semplicemente, un “signore” (“Saitta”), un tipo con l’aspetto da “pretino” (“Papotto”), un “compagnone” (“Conti”), uno “bello come un rubino” (“Rubino”), etc.
Un’ultima osservazione per i patronimici. Dei tre considerati solo uno, “De Luca”, possiede la particella “de” anziché “di” (come per “Di Vincenzo”e “Di Marco”). Spesso, per alcuni cognomi italiani, tale particella è indicativa di nobiltà. Il cognome brontese “De Luca”, come è attestato nei registri parrocchiali più antichi, risulta trascritto semplicemente come “Luca” o “di Luca”. Il “de” è dunque una variazione postuma, probabilmente sorta, ancora una volta, per distinguere una famiglia che ha raggiunto un elevato status socio-economico dalle omonime. Al secondo posto, per consistenza, troviamo i cognomi toponimi ed etnici. Tra i toponimi rileviamo 14 località siciliane. Diffusissimo il cognome “Catania”; molto meno la forma “Messina”; segue, per ultimo, il cognome “Palermo”. Cirami (Cerami), Piazza (Armerina), Sanfilippo (d’Agira) appartengono all’Ennese; Gangi alla Sicilia occidentale. Diversi i centri del Messinese: Capizzi, Castiglione di Sicilia, Galati, Galvagno, Pace (del Mela). Alla Sicilia del centro-sud appartengono i toponimi Sciacca e Minìo (Mineo). Toponimi non siciliani sono: Avellina (Avellino) e Caserta (Campania), D’Aquino (Lazio) e Franco (Navarra, Spagna). Toponimi ed etnici sono cognomi indicatori per lo più di movimenti migratori. Con il nome della località di provenienza, o con l’indicazione di una etnìa, infatti potevano essere designati gruppi più o meno consistenti di persone, che, per differenti motivi (persecuzioni, ricerca di lavoro, etc.), migravano verso nuove località.
È noto, per esempio, che numerosi cognomi ebraici siano toponimi: le continue persecuzioni cui erano sottoposti, costringevano gli ebrei a continui spostamenti verso centri più sicuri e tolleranti. Qui, essi perdevano i loro cognomi originari, per assumere il nome della città di provenienza. In effetti, i toponimi brontesi Catania, Messina, Palermo, Minio (Mineo), Sciacca, rinviano a città e paesi nei quali esistevano fiorenti comunità ebraiche ed è probabile dunque che possano essere cognomi di origine ebraica. È però altrettanto vero che anche immigrati non ebrei, principalmente i lavoratori stagionali, accolti in un nuovo paese, potevano essere indistintamente denominati con il nome delle località d’origine (per esempio, “i Longhitano”, da Longi; “gli Scalisi”, da Scalea, etc).
L'origine dei toponimi
 Un’ultima osservazione, infine, sull’origine dei toponimi: un toponimo poteva anche essere assegnato ad un trovatello, che veniva così cognominato con il nome del luogo dove era nato. Un’ultima osservazione, infine, sull’origine dei toponimi: un toponimo poteva anche essere assegnato ad un trovatello, che veniva così cognominato con il nome del luogo dove era nato.
Analizzando gli etnici “Lombardo” e “Greco”, ci imbattiamo in significativi marcatori linguistici nei quali leggiamo, ancora un volta, importanti pagine della storia siciliana. I “lombardi” erano infatti popolazioni provenienti dalla Italia nord-occidentale, che, sotto gli auspici dei Normanni e degli Svevi, migrarono in Sicilia, con lo scopo di colonizzare e rinvigorire demograficamente le zone spopolate e più impervie dell’isola.
Nuclei consistenti di “lombardi” si attestarono lungo tutta la dorsale peloritana del Messinese, dando origine al sorgere di interessanti realtà economiche e culturali (si pensi, per rimanere in ambito linguistico, al dialetto gallo-italico di S. Fratello). Per quanto concerne il toponimo “Greco” (in siciliano, “gricu”), esso non deve far pensare ad una memoria linguistica che ricordi la presenza degli antichi greci a Bronte. La colonizzazione greca interessò e influenzò in maniera preponderante altre zone della Sicilia orientale. Tale termine connotava, invece, in epoca medievale e moderna, genti provenienti dai Balcani, per lo più di origine albanese. La presenza degli albanesi nell’Italia meridionale rimonterebbe, per la prima volta, al tardo Trecento, come mercenari nelle lotte intestine tra la grande feudalità, la monarchia angioina e la corona aragonese. Altri importanti flussi migratori avverranno nel 1500 a seguito dell’avanzata turca nel Balcani. Consistenti gruppi di albanesi rappresentarono una importante componente etnica che costituì, insieme ad altre popolazioni, in età moderna, il nucleo originario di Bronte. Variegato è l’ambito dei cognomi brontesi indicanti i mestieri: tra gli artigiani e i commercianti ritroviamo i calzolai (“Zingale”), i venditori di stuoie (“Cassarà”), i “Cordari”; non mancano gli “Orefice” (cognome presente anche tra i cognomi ebraici), i droghieri (“Lombardo”), gli operai tessili (“Mancani”) e i parrucchieri (“Attinà”). Tra le attività legate al mondo della natura annoveriamo i mielai (“Minissale”), gli ortolani (“Laganà”) e i cacciatori di uccelli (“Uccellatore”). In ambito medico-assistenziale troviamo gli “Spitaleri” e i “Ciraldo. Completano l’elenco dei cognomi di mestiere i “custodi di ingressi conventuali” (“portaro”) e i “carnefici” (“Burrello”), se facciamo discendere tale forma linguistica dal termine francese borrel. Per quanto riguarda i cognomi tratti dal mondo della natura, in ambito vegetale non potevano mancare i fiori (“Azzara”), il grano (“Catania”), le cipolle (“Cipolla”), le fave (“Favazza”), la lattuga (“Marullo”), la vite (“Rappazzo”) e, derivato dai fiori, il miele (“Meli”). Nel mondo animale rileviamo i gatti (“Gatto”), l’ùpupa (“Lupica”), il lupo (“Lupo”), il merlo (“Marullo”), l’oca (“pàparo”), la pecora (“Pecorino”), il fringuello (“Pinzone”), il riccio (“Rizzo”). I fulmini (“Saitta”) e i monti (“Montagno”) fanno da sfondo a tale panorama. Non è improbabile che molti di tali cognomi fossero usati in senso figurato, dato che l’uomo ha da sempre tessuto delle corrispondenze e delle analogie con il mondo animale e vegetale, proiettandovi attributi psicologici e fisici. Animali, piante ed eventi naturali, finiscono così per trasformarsi in simboli o metafore di determinate qualità antropomorfiche. Tra i cognomi riferibili agli oggetti, reperiamo bisaccie di grandi dimensioni (“Bertolone”) e, all’opposto, sacchi di picco- le dimensioni (“Saccullo”). Ancora: recipien- ti vari di terracotta (“Cannata”, “Lembo”, “Pruiti”) e poi dei semplici ciottoli (“Fallico”), ma anche parti delle stadere (“Romano”) e, infine, addirittura, dei cem- bali (“Cimbali”). I cognomi indicanti parti del corpo sono solamente due, ma fanno significativamente riferimento a due organi di vitale importanza per l’uomo, ovvero l’intestino (“Burrello”) e il cervello (“Ma rullo”). Alla “vita” e alla “lealtà” (o all”‘alleanza”) fanno infine riferimento gli unici due cognomi brontesi derivanti da nomi astratti.
L'origine linguistica
Dopo averne considerato l’aspetto semantico (relativo al significato), completiamo la nostra ricognizione onomastica, analizzando l’origine linguistica dei cognomi brontesi. Ecco l’elenco dettagliato per cognome dei suddetti sostrati linguistici:  - Cognomi di origine latina (nn. 39): - Cognomi di origine latina (nn. 39):
Amato, Barbagiovanni, Bonsignore, Biuso, Capace, Caserta, Castiglione, Cipolla, Conti, Cordaro, Costanzo, Correnti, Destro, Luca (De), Favazza, Fazio, Gatto, Greco, Isola, Lupo, Uccellatore, Màncani, Marco (Di), Marcantonio, Marino, Martelli, Marullo, Mirenda, Montagno, Orèfice, Pace, Pecorino, Piazza, Ponzo, Reale, Romano, Rubino, Sano (Di), Vincenzo (Di).
- Cognomi di origine greca, tardo-greca, bizantina, albanese (nn. 40):
Anastasi, Attinà, Basile, Calà, Calì, Calanna, Cannata, Capizzi, Caraci, Catania, Cartillone, Ciraldo, Cirami, Fàllico, Faranda, Foti, Galati, Gangi, Germanà, Gorgone, Grassia, Grìgoli, Gullotto, Imbrosciano, Laganà, Messina, Messineo, Minissale, Pafumi, Palermo, Papotto, Petronaci, Politi, Pruiti, Sanfilippo, Scalisi, Schilirò, Tirendi, Zerbo, Zingale. - Cognomi di origine siciliana (nn. 20):
Bertolone, Burrello, Cannata, Caruso, Cìmbali, Ciraldo, Lembo, Meli, Minio, Mirenda, Pàparo, Pinzone, Portaro, Rappazzo, Rizzo, Russo, Saccullo, Saitta, Sciacca, Spitaleri. - Cognomi hanno invece origine da sostrati linguistici medievali di origine normanna, longobarda, germanica, gallo-italica (nn. 12):
Bonaccorso, Bonina, Burrello, Franco, Galvagno, Gulino, Lenza, Lombardo, Pappalardo, Prestianni, Uccellatore, Vitanza.
- Cognomi di origine araba (nn. 9):
Azzara, Batticani, Camuto, Caraci, Cassarà, Catania, Musarra, Saitta, Sciacca. - Cognomi ebraici (nn. 3):
Làzzaro, Liuzzo, Rubino. Di probabile origine napoletana è invece Lùpica. I sostrati linguistici dominanti sono dunque il latino e il greco (incluso il greco medievale e il bizantino), a conferma del profondo radicamento di queste civiltà nel corso degli eventi storici della Sicilia. Seguono poi i cognomi siciliani, (alcuni dei quali sono comunque di derivazione latina o greca); poi, quelli derivanti dal sostrato nordico (germanico, gallo-italico, longobardo).
Chiudono l’elenco le forme di origine araba, ebraica e una di ascendenza napoletana.
P.S. Postilla minima di riflessione sul significato del presente articolo.
Uno degli esiti del processo di “massificazione” nell’ambito della società post-moderna, connesso al fenomeno di una onnipervasiva “globalizzazione”, alimenta, in termini problematici, la questione della definizione delle nostre matrici individuali in relazione al confronto-scontro tra identità, culture, percorsi storici anche sensibilmente differenti.
Su questo crinale, chiaroscurale e magmatico, si spiega il crescere della domanda di riscoperta delle proprie “radici” storiche, anche a partire dalla microstoria individuale e familiare. Nel cognome che ciascuno di noi eredita dai suoi antenati, ovvero il nome distintivo della propria famiglia, si esprime un intreccio di informazioni che variano all’interno di ambiti culturali differenti, tra i quali la linguistica, la geografia, la genealogia, la genetica e (per ultima ma non ultima) la storia.
Tentare di penetrare questi aspetti, relativi alla vicende remote di coloro che nel tempo ci hanno preceduto e che per primi hanno portato il nostro cognome, significa stimolare interrogazioni nuove, e più ampi orizzonti di ricerca, volti ad illuminare scenari inediti del passato, nel tentativo di costruire “orizzonti di senso” che possano sostenere il nostro presente, insidiato e avvilito da una deprimente disvaloriale cultura antistorica. Pietro Spitaleri Perdicaro [L’articolo è stato pubblicato anche su “D’inverno un viaggiatore”, rivista di studi e ricerche sul territorio di Bronte e della Ducea dei Nelson, anno II, n. 2 dicembre 2007]
|